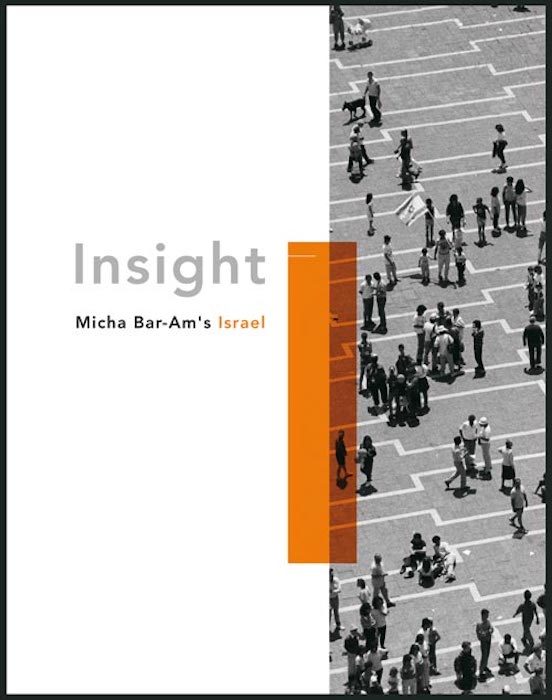Modalità di raffigurazione della guerra. Atti Giornate di Studio. Parte II. 1a edizione. A cura di Punto di Svista
Pubblichiamo la trascrizione del seminario tenutosi nell’ambito del primo appuntamento della Giornate di Studio sulla Fotografia Documentaria e il Fotogiornalismo di Roma, a cura di Punto di Svista e Officine Fotografiche. Si tratta del seminario, tenuto da Maurizio G. De Bonis, sulla autorappresentazione dei fotografi e cineasti israeliani all’interno del conflitto con il mondo arabo-palestinese.
La redazione ha scelto di mantenere nella trascrizione il tono diretto, non accademico e colloquiale utilizzato durante il seminario. Potranno essere riscontrate nel testo ripetizioni di termini e frasi complesse tipiche della lingua parlata. Si è scelto di pubblicare questo tipo di testo per restituire al lettore non solo la sostanza del seminario ma anche, appunto il suo tono originale.
Per esigenze comunicative, la trascrizione del seminario, durata tre ore, sarà pubblicata in tre parti.
E’ POSSIBILE RACCONTARE UN CONFLITTO?
MODALITA’ CONTRADDITTORIE DELLA RAFFIGURAZIONE DELLA GUERRA
Seminario tenuto da Maurizio G. De Bonis (critico cinematografico e fotografico, presidente di Punto di Svista)
SECONDA PARTE
A questo punto io andrei alla parte fotografica. Iniziamo finalmente questo cammino fotografico dentro la storia della fotogiornalismo e della fotografia israeliana. Allora, ci sono una serie di nomi che io voglio studiare insieme a voi per capire esattamente cosa significa autorappresentarsi dentro un conflitto, autoanalizzarsi, vivere questa condizione di angoscia. E’ un’autoterapia attraverso le immagini, attraverso l’uso del linguaggio visivo in un percorso difficile che a volte condiziona tutta un’intera esistenza, nel tentativo di capire se stessi ma anche contemporaneamente di capire gli altri.
 Iniziamo da Micha Bar-Am. Iniziamo da questo fotografo considerato il padre della fotografia israeliana. È un uomo barbuto, che adesso ha più di 80 anni, che vive in una città limitrofa a Tel Aviv, Ramat Gan, e che ha dato alla fotografia mondiale tantissimo, ma nessuno in Italia lo sa (forse pochissimi). Tanto per fare un esempio, Micha Bar-Am è dal 1968 dentro Magnum; è dunque un fotografo Magnum, è un vero fotogiornalista che ha contribuito con il suo lavoro anche al consolidamento di questa grande agenzia. Ma non solo, Micha Bar-Am è stato co-fondatore dell’International Center of Photography di New York insieme a Cornell Capa. Negli Stati Uniti è un fotografo conosciuto proprio per il tipo di lavoro che ha fatto sul concetto di conflitto e sulla propria condizione di fotografo dentro il conflitto. Per 25/26 anni è stato corrispondente del New York Times da Israele, e ha documentato attraverso la macchina fotografica tutti i conflitti arabo-israeliani. E’ stato una sorta di veicolo di informazioni per il mondo intero. Per molti anni è stato a capo del dipartimento di fotografia (attenzione di fotografia, non di fotogiornalismo) del Museo d’Arte Contemporanea, un museo molto prestigioso. Dunque, è un fotografo importante e assolutamente sconosciuto in questo paese. E’ apparso rarissime volte, l’ultima qualche anno fa durante una collettiva sulla fotografia israeliana contemporanea nell’ambito del Festival Internazionale di Fotografia di Roma, una mostra che è stata al Museo Andersen della Galleria Nazionale d’Arte Moderna curata da Orith Youdovich.
Iniziamo da Micha Bar-Am. Iniziamo da questo fotografo considerato il padre della fotografia israeliana. È un uomo barbuto, che adesso ha più di 80 anni, che vive in una città limitrofa a Tel Aviv, Ramat Gan, e che ha dato alla fotografia mondiale tantissimo, ma nessuno in Italia lo sa (forse pochissimi). Tanto per fare un esempio, Micha Bar-Am è dal 1968 dentro Magnum; è dunque un fotografo Magnum, è un vero fotogiornalista che ha contribuito con il suo lavoro anche al consolidamento di questa grande agenzia. Ma non solo, Micha Bar-Am è stato co-fondatore dell’International Center of Photography di New York insieme a Cornell Capa. Negli Stati Uniti è un fotografo conosciuto proprio per il tipo di lavoro che ha fatto sul concetto di conflitto e sulla propria condizione di fotografo dentro il conflitto. Per 25/26 anni è stato corrispondente del New York Times da Israele, e ha documentato attraverso la macchina fotografica tutti i conflitti arabo-israeliani. E’ stato una sorta di veicolo di informazioni per il mondo intero. Per molti anni è stato a capo del dipartimento di fotografia (attenzione di fotografia, non di fotogiornalismo) del Museo d’Arte Contemporanea, un museo molto prestigioso. Dunque, è un fotografo importante e assolutamente sconosciuto in questo paese. E’ apparso rarissime volte, l’ultima qualche anno fa durante una collettiva sulla fotografia israeliana contemporanea nell’ambito del Festival Internazionale di Fotografia di Roma, una mostra che è stata al Museo Andersen della Galleria Nazionale d’Arte Moderna curata da Orith Youdovich.
Partirei con la prima immagine: questa è una tra le più conosciute di Micha Bar Am. E’un’immagine emblematica del discorso che noi abbiamo fatto fino a ora. Ci troviamo nella guerra di Kippur, una delle più tragiche guerre del Medio Orinete, una delle più violente e una delle più difficili al livello di risoluzione politica. Tra l’altro fu una guerra scatenata da Egitto e Siria che da confini diversi attaccarono Israele nel giorno del Kippur, il giorno più sacro per gli ebrei di tutto il mondo in cui in Israele praticamente tutto è fermo e dunque rappresentava sotto il profilo della strategia bellica un momento ideale per attaccare Israele, e questo fu fatto. Fu una guerra tragica che provocò in pochi giorni migliaia di morti.
Micha Bar-Am lavorava dentro i conflitti con lo sguardo del fotografo che conosce perfettamente che cosa significhi stare dentro un conflitto. E stare dentro un conflitto significa nella stragrande maggioranza dei casi viverlo nella sua dimensione delirante. Micha Bar-Am si trova in questo momento in una zona in cui l’esercito e l’aviazione egiziana bombardano insieme soldati israeliani e prigionieri egiziani. Si tratta di un’immagine chiara di cosa significhi vivere il conflitto nella dimensione umana. Magari un’ora prima questi soggetti si sparavano, cercavano di uccidersi a vicenda. Un’ora dopo tutto questo sistema di potere inizia a perdersi completamente. Il delirio della guerra, lo sparare senza sapere dove si sta sparando provoca che cosa? Il totale annullamento delle separazioni conflittuali. In questo momento i soldati, diciamo così, che hanno vinto la precedente battaglia e i loro prigionieri diventano la stessa cosa, rischiano insieme la vita. Certo, in una condizione diversa (ci sono soldati vincitori e i prigionieri), ma sostanzialmente il rischio della vita è in questo momento assolutamente condiviso e portato avanti nella completa insensatezza di quella che sta avvenendo. Gli egiziani bombardano, ma in questo caso bombardano anche i loro commilitoni. Eventi che nella guerra succedono in continuazione. Ecco, Bar-Am fotografa questo passaggio che è di assoluta importanza per evidenziare non tanto chi abbia ragione, chi sia il più forte, ma per descrivere come si trovi l’essere umano all’interno di un conflitto bellico. Il senso delle azioni umane perde completamente la sua direzione e individui nemici si ritrovano a condividere la paura della morte insieme. Questa fotografia di Micha Bar-Am che è una delle sue più famose, è una fotografia che poi, attraverso il suo senso profondo, troviamo in molti film.
Ricordo una scena de Salvate il Soldato Ryan di Spielberg in cui a un certo punto durante una battaglia tra tedeschi e americani un soldato delle SS e un soldato americano dentro una casa abbandonata si ritrovano faccia a faccia a un millimetro e in quel momento invece di scannarsi e di spararsi, si guardano, per molti secondi, e poi ognuno va per la sua strada. Mi viene in mente il film che ho citato prima Lebanon di Samuel Maoz, in cui a un certo punto una sequenza si conclude con un prigioniero siriano (con le mani legate) dentro un carro armato israeliano che deve urinare e il soldato israeliano prende in mano il pene del nemico e lo aiuta a urinare. Ecco, queste sequenze, queste immagini, ci raccontano molto più della guerra rispetto tutto il ciarpame che viene pubblicato sui giornali e che non ha alcun senso se non quello della spettacolarizzazione il dolore.
Andiamo avanti. Questa è un’altra immagine significativa di Micha Bar-Am. Che come vedete non ha paura di inquadrare la realtà che lui vive, anche se questa realtà è difficile da accettare. Lui è israeliano, si trova dentro i conflitti, e quindi vive questa condizione di dover stare a guardare da una certa parte. Questi sono palestinesi, messi in questa condizione, catturati e guardati, come vedete, da soldati israeliani. Che cosa ci vuole raccontare con questa immagine Micha Bar-Am? Il cortocircuito degli sguardi nel momento in cui si verifica la guerra, nel momento in cui qualcuno prende il potere sugli altri. I prigionieri sono privati del proprio sguardo e della propria capacità di guardare, coloro che li hanno catturati li guardano. È un cortocircuito vero e proprio. Si tratta di un’immagine che più di molte altre immagini in cui vediamo morte e sopraffazione ci comunica il grado zero del livello di comunicazione umana all’interno di un conflitto.
Andiamo avanti. Questa è un’immagine che mi ha fatto sempre riflettere molto. Perché è un’immagine in cui Micha Bar-Am si sofferma sul cadavere di una persona, durante un’operazione bellica perché sullo sfondo vediamo dei soldati che si stanno quasi proteggendo, alcuni dietro un muro, altri probabilmente si stanno accampando. Questa fotografia ci comunica la separazione dal punto di vista della comunicazione umana tra un esercito in guerra che pensa all’azione militare e il dolore di queste persone sedute accanto a un muro che piangono il loro amico, il loro parente, la persona morta che amavano e che non gli verrà mai più restituita. C’è come un’interruzione di senso in queste due porzioni dell’immagine. Una porzione non dialoga con l’altra porzione dell’immagine.
Andiamo avanti. Questa è un’altra immagine che potremmo equiparare a quella che abbiamo visto all’inizio. È Micha Bar Am che si trova su un convoglio militare sotto attacco in cui il suo sguardo diviene una sorta di gigantesca e tragica soggettiva sulla condizione del soldato. Lasciamo perdere adesso che si tratta di soldati israeliani, potrebbero essere americani, potrebbero essere di qualsiasi nazionalità. La condizione che vive il soldato nell’atto della guerra, cioè nella condizione della fragilità è perfettamente materializzata attraverso questo sguardo. Perché essendo dentro il corpo dell’azione, percependo in maniera fortissima la preoccupazione, la paura di questi soldati attraverso questo tipo di inquadratura, riusciamo a vivere e a percepire in una maniera netta la sensazione della paura, che è una sensazione difficile da raccontare attraverso le immagini e in genere viene sempre tralasciata dalle immagini che raccontano e rappresentano la guerra.
Andiamo avanti. Micha Bar-Am ci fa vedere un’altra cosa. Si tratta di soldati israeliani durante una pausa del conflitto. Questo aspetto non viene mai mostrato. Si pensa sempre che una battaglia si esaurisca esclusivamente nell’atto di attaccare il nemico, di compiere l’azione. Invece ben sappiamo, proprio dai fotografi israeliani-soldati che sono stati dentro i conflitti che la stragrande maggioranza delle battaglie e dei conflitti bellici si articola attraverso le attese, cioè attraverso il nulla. E noi sappiamo che proprio nei momenti in cui l’attesa prende il sopravvento per molte ore sull’azione bellica che il soldato ragiona sull’essenza della propria condizione.
Andiamo avanti. E’ un’immagine in cui Micha Bar-Am si confronta con la questione del corpo del prigioniero, il corpo del prigioniero costretto da lacci, prigionieri trasportati in una dimensione delirante per la condizione umana, per la libertà del corpo. Ma questa condizione riguarda tutti i prigionieri di guerra e questa mancanza di libertà poi diviene mancanza di pensiero; si finisce per non pensare più se non alla propria condizione di essere vivente in una negata libertà. Di nuovo torniamo al problema centrale che questa fotografia comunica in maniera precisa: Conflitto = assenza di comunicazione = assenza di pensiero.
Altra immagine tra le più note di Micha Bar-Am, che tra l’altro è stata esposta a Roma alla mostra che vi ho detto di qualche anno fa e che ha innumerevoli letture di carattere metaforico-simbolico. Lo sguardo in macchina di questa donna dai tratti beduini che porta sulla propria testa probabilmente un fascio di arbusti. Questo sguardo racconta cosa? Non racconta tanto l’essenza di questa persona che certamente è presente. Racconta qualcosa d’altro. Questo sguardo è un paesaggio. Il paesaggio della guerra. Il paesaggio dell’impossibilità di questa persona di comprendere esattamente quello che avviene a lei, nel suo posto, tra la propria gente, in quella condizione. Questo paesaggio della guerra è caratterizzato anche dalla presenza ambigua di un soldato che si avvicina in maniera circospetta. È una figura ambigua dicevamo; è allo stesso tempo minacciosa e piena di paura. Sembra quasi camminare con grande attenzione, avvicinarsi a questa persona-paesaggio. L’azione che compie questa donna che cosa vuole significare? In guerra e durante i conflitti bellici spesso si crea questo meccanismo di indecifrabilità dei gesti. Perché? Perché la paura genera il sospetto. La comunicazione si interrompe e Micha Bar-Am in questa inquadratura, miracolosamente perfetta, riesce a evidenziare l’insensatezza dell’istante nel quale si è imbattuto.
Qui Micha Bar-Am ci fa vedere quanto la sua azione sia articolata, come intenda rappresentare la condizione di un intero popolo attraverso tutte le sfaccettature, attraverso tutti i punti di vista che un fotogiornalista può far emergere. Ci troviamo nel cuore di Tel Aviv nell’ambito di una manifestazione pacifista della sinistra israeliana. Ecco che Micha Bar-Am punta il proprio obbiettivo non solo sul conflitto e sulla condizione di mancanza di comunicazione tra persone che si combattono. Punta il proprio obiettivo sulla autocoscienza di un paese, di un popolo, che in una certa sua parte cerca di comprendere fino in fondo anche le ragioni dell’altro. L’autore cerca di rappresentare attraverso un meccanismo sfaccettato quello che implica per un paese così piccolo come Israele la condizione di un conflitto. Il soldato che va a combattere, che fa prigionieri, ma che magari un anno prima partecipava a questo tipo di manifestazioni e che continua a vivere una sorta di scissione interiore tra la propria anima pacifista e la propria anima patriottica.
Altra foto storica di Micha Bar-Am. Qui siamo saltati ancora in un’altra situazione, in un’altra condizione. Si pensa sempre al soldato israeliano, all’esercito israeliano, come qualcosa di molto duro e potente. Probabilmente è così. Ma non si pensa e non si analizza mai quali siano le implicazioni sociali e umane di un popolo che da 60 anni è costretto, ripeto non parliamo di politica assolutamente, a stare dentro un conflitto. Si pensa sempre che un soldato israeliano sia estraneo alla realtà, ma non è così. Dietro ci sono degli affetti, c’è una casa, una città con ospedali, uffici, attività, esseri umani esattamente come tutti e tutti si ritrovano sulla stessa barca. Con lo stesso tipo di sentimenti. Parlo ovviamente, e lo ripeto, di esseri umani, non delle azioni dei governi, non delle politiche.
In questo caso, Micha Bar-Am evoca il ritorno a Tel Aviv dei soldati che hanno compiuto delle azioni più pirotecniche che l’esercito sia mai riuscito a compiere. Questa fotografia si intitola Ritorno da Entebbe, e in particolare fa riferimento all’incontro tra un ostaggio israeliano e i suoi familiari. Entebbe significa Uganda, e significa azione di salvataggio di centinaia di ostaggi di un aereo che doveva andare da Atene a Parigi, aereo che aveva al suo interno moltissimi israeliani ma anche molti cittadini di altre nazionalità, compresi degli italiani. Quest’aereo fu dirottato appunto in Uganda, i passeggeri furono presi in ostaggio da guerriglieri palestinesi e Israele decise di compiere una missione impossibile; aerei militari israeliani volarono fino in Uganda senza farsi cogliere dai radar del mondo intero (praticamente), atterrarono all’improvviso in questo aeroporto africano; ci fu un conflitto a fuoco non solo con i terroristi che sequestrarono ma anche con l’esercito ugandese. Alla fine i soldati israeliani riuscirono a portare indietro quasi tutti gli ostaggi. Ci furono dei morti, molti ugandesi, i guerriglieri palestinesi. Il ritorno in Israele di questi soldati che avevano realizzato quest’operazione fu vissuto come una sorta di grande sollievo nazionale. Gli ostaggi portati in Uganda erano stati tratti in salvo da alcuni uomini che avevano rischiato tutto per farlo. Questi uomini avevano in realtà una rete di relazioni profonde con i propri familiari e che si trovavano in questo momento, al ritorno da questa azione non più militari ma esseri umani che avevano perso la propria condizione di soldati ed erano ridiventati agli occhi dei propri familiari individui da amare, che avrebbero provocato dolore nel caso della loro scomparsa. È una sorta di sollievo collettivo che allude all’angoscia perenne vissuta all’interno di questo paese .
Questa è un’altra immagine simbolica (Evacuation of Yamit, 1982). Perché tutti noi abbiamo visto negli ultimi anni il ritiro da Gaza. Ma per quanto riguarda la storia di Israele, qui Micha Bar-Am ci fa vedere che gli sgomberi dei territori occupati durante le varie guerre è avvenuto in molte circostanze. Questo è lo sgombero del Sinai, che è il territorio strappato agli egiziani. E in questo momento, attraverso questa immagine, il fotografo ferma in una maniera molto precisa, il conflitto all’interno della stessa popolazione Israeliana. I soldati che prima hanno fatto la guerra all’Egitto e hanno conquistato questo territorio adesso si trovano nelle condizioni di dover portare via dei civili che lì si sono insediati. Pensate a quale livello di angoscia e di contrasto sociale e umano si può arrivare in queste condizioni.
Ora volevo farvi vedere anche un’altra immagine importante per la storia di questo fotografo. La capacità anche di guardare attraverso l’obiettivo della propria macchina fotografica qualcosa che non sia solo il conflitto, ma che rappresenti una sorta di crescita, di uscita dal conflitto, un tentativo di trovare una salvezza dal conflitto, anche attraverso l’uso della macchina fotografica.
Quest’immagine è stata scattata nel 1991. Molti di noi non sanno che cosa sia, perché anche gli organi di informazione non ne parlarono in maniera così circostanziata come avrebbe meritato. Nel 1991 c‘era una feroce guerra civile in Etiopia. E le minoranze etnico-religiose rischiavano moltissimo. Questa minoranza che vedete inquadrata è conosciuta solo da chi si occupa di certi argomenti, ma ha una storia complessa e anche misteriosa. Si tratta degli ebrei etiopi, quelli che vengono da certuni definiti Falascià, un’antica popolazione ebraica vissuta nel cuore dell’Africa per millenni, minoranza che si trovava in pericolo assoluto di sopravvivenza. In quei giorni si decide di procedere alla salvezza di questa popolazione. E viene messo in atto il più grande ponte aereo della storia. Per circa 36 ore, oltre 30 veicoli israeliani, facendo un ponte aereo continuo, portano in Israele e salvano da morte 15000 ebrei etiopi attraverso una delle più gigantesche operazioni di salvataggio nella storia dell’umanità. Si dice addirittura, e non so se queste immagini si riferiscano a questo volo, che l’ultimo carico disperato che fu fatto dall’ultimo aereo israeliano che era riuscito ad atterrare in Etiopia e comportò l’ingresso dentro l’aereo di più di 1000 persone, molto oltre il carico che l’aereo avrebbe potuto sopportare.
Ora, questa è un’operazione gigantesca che Micha Bar-Am ha voluto a tutti i costi documentare. Perché rappresentava una sorta di completamento del lavoro profondo sulla condizione del proprio paese, del proprio popolo, sulla assunzione di responsabilità all’interno del conflitto. Ma era necessario anche documentare cosa succedeva in quegli anni per una minoranza ebraica sottoposta a vessazioni e difficoltà enormi e che doveva essere salvata.
(fine seconda parte)
© Punto di Svista 07/2011
IMMAGINE
Copertina del volume Insight – Micha Bar-Am’s Israel
INFORMAZIONI
Atti delle Giornate di Studio sulla Fotografia Documentaria e il Fotogiornalismo / A cura di Punto di Svista e Officine Fotografiche
Dal 18 al 20 maggio 2011
E’ possibile raccontare un conflitto? Modalità contraddittorie della raffigurazione della guerra / seminario tenuto da Maurizio G. De Bonis (Punto di Svista) mercoledì 18 maggio, dalle 18.00 alle 21.00
LINK – ATTI DELLE GIORNATE DI STUDIO SULL’IMMAGINE DOCUMENTARIA
- E’ possibile raccontare un conflitto? Modalità contraddittorie della raffigurazione della guerra – PRIMA PARTE
- E’ possibile raccontare un conflitto? Modalità contraddittorie della raffigurazione della guerra – TERZA PARTE
- La questione dell’immagine fotografica tra oggettività, soggettività, realtà, ricordo e immaginazione
- Cercare, scoprire, vedere, raccontare. La fotografia come strumento di conoscenza
- Cosa vuol dire essere fotogiornalisti oggi?
ALTRI LINK
Il sito di Micha Bar-Am